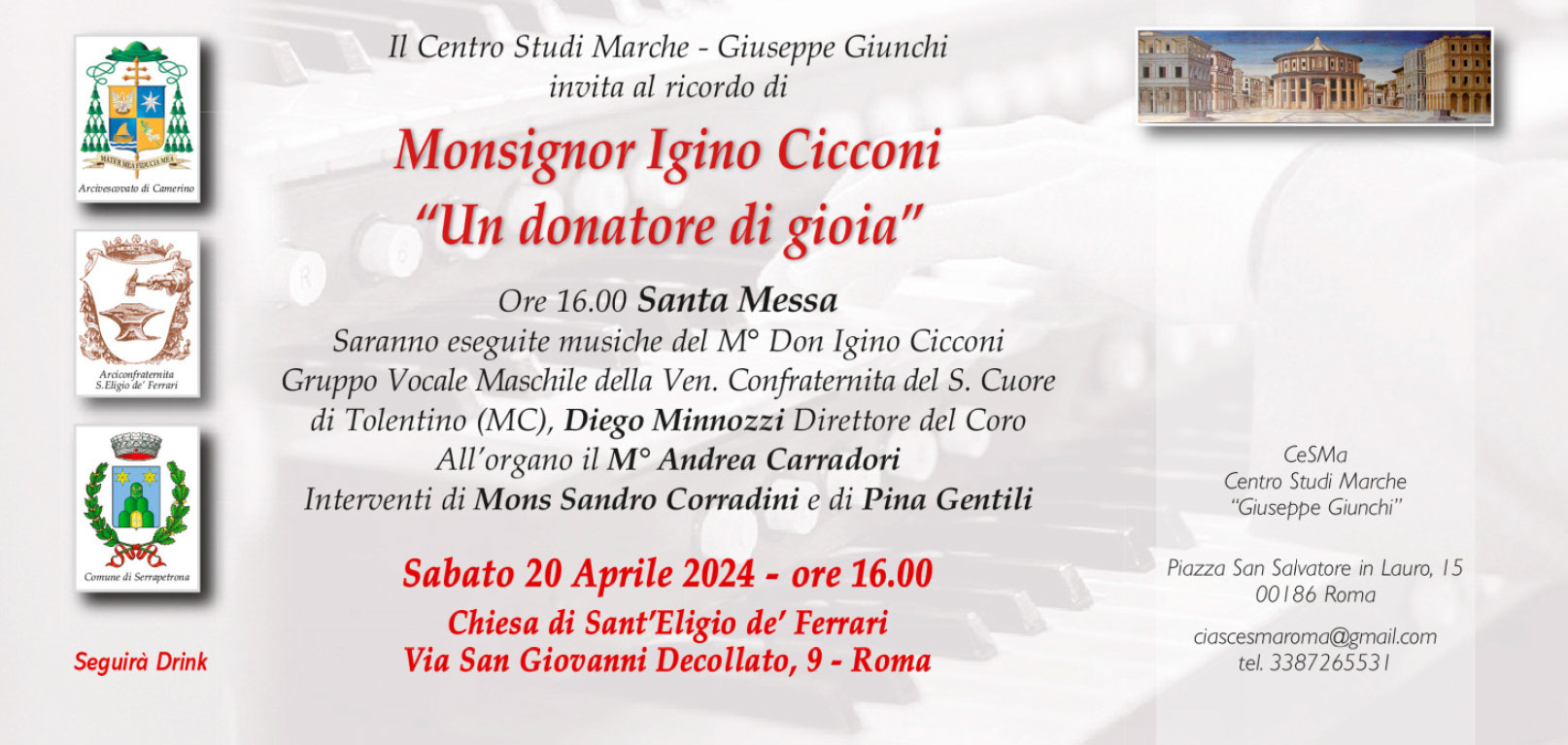Giovedì 30 maggio alle ore 17:00, nella Sala Capitolare del Senato della Repubblica, si è svolta la cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento “Picus del Ver Sacrum 2023 — Marchigiani dell’Anno”. Il premio, conferito annualmente dal Centro Studi Marche “G. Giunchi” a marchigiani che si sono particolarmente distinti per meriti professionali, scientifici, artistici, culturali e sociali, è stato istituito nel 1986 dal professor Armando Mazzoni, allora Presidente del Ce.S.Ma.
Questa la rosa dei premiati di questa 38a edizione:
UGO BELLESI — Giornalista — Storico della gastronomia marchigiana (MC)
ROSARIA DEL BALZO RUITI — Presidente Croce Rossa (MC)
VITTORIO CAMAIANI — Stilista (AP)
EMANUELE FRONTONI — Professore ordinario di Informatica Università Macerata (FM)
FRANCESCO LOMBARDO — Imprenditore (MC)
GIULIO MAURIZI — Chirurgo Toracico e Professore universitario (MC)
MICHELA MERCURI — Docente universitaria, scrittrice (FM)
ELISA E PAOLO SCENDONI — Imprenditori (FM)
DARCO PELLOS — Prefetto di Venezia (PU)
PAOLO PAGNOTTELLA — Ammiraglio (PU)
Sono stati inoltre assegnati il premio Marchigiano ad Honorem (17a edizione) all’Ambasciatore d’Italia, Segretario Generale dell’Iniziativa Adriatico Ionica (IAI) GIOVANNI CASTELLANETA e il premio Marchigiano nel Mondo (9a edizione) a LORENA NOÉ, Presidente Associazione Marchigiani a Genk — Belgio.
Le opere d’arte consegnate ai premiati sono state realizzate dall’artista Silvio Cattani e sono gentilmente donate dall’azienda pesarese Fiam di Vittorio Livi.
Alla cerimonia di premiazione, che è stata aperta dai saluti istituzionali (on line) del Senatore Questore del Senato della Repubblica Antonio De Poli, hanno preso parte l’Ambasciatore Giorgio Girelli e la giornalista Rosanna Vaudetti.
Sono intervenuti per la lettura dei curriculum e delle motivazioni gli attori Simone Pieroni e Roberta Sarti. L’evento, organizzato dalla direttrice del Ce.S.Ma Pina Gentili, è stato trasmesso in diretta streaming al https://webtv.senato.it/ e sul canale YouTube del Senato Italiano https://www.youtube.com/user/SenatoItaliano